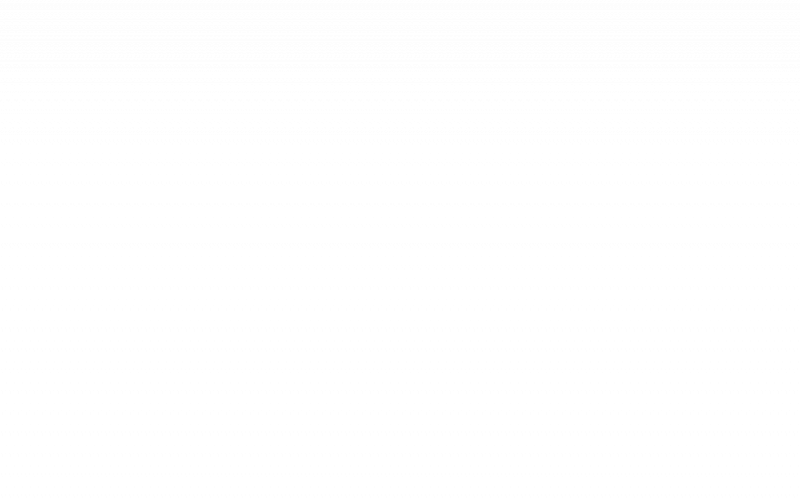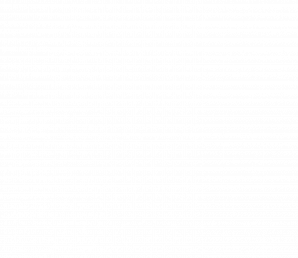Ha avuto una certa eco anche in Italia la decisione della catena americana di farmacia Rite Aid, terza negli Usa per filiali, di ricorrere al cosiddetto “capitolo 11”, l’equivalente del nostro concordato fallimentare. È vero che hanno spinto per tale soluzione le pesantissime sanzioni che la giustizia americana dovrebbe infliggere a Rite Aid – così come alle altre catene americane di farmacia – per il cosiddetto “scandalo degli oppioidi”, ma è anche vero che la procedura le consentirà di chiudere le farmacie della sua rete che attualmente sono in perdita, un numero che al momento resta ignoto ma arriva a qualche centinaio. È l’ennesimo campanello di allarme dopo quelli già suonati di recente con altre insegne: pochi giorni fa Wba ha sostituito in fretta e furia il proprio ceo dopo un anno di perdite in borsa, Boots Uk continua a non trovare compratori, LloydsPharmacy (la catena inglese che McKesson ha venduto un anno fa al fondo di equity Aurelius) ha sfoltito la rete delle sue farmacie vendendo le filiali in sovrannumero una a una, visto che non c’erano offerte per l’acquisto in blocco.
Dal mondo anglosassone, in sostanza, sembra arrivare un messaggio evidente: il format delle grandi catene di pharmacy retail è in sofferenza. Epperò, questo è il modello che oggi continua a ispirare le insegne di farmacia del nostro Paese, nonostante bilanci che nella grande maggioranza dei casi non mostrano numeri brillanti nemmeno nel 2022. In particolare, i fatturati delle filiali del capitale risultano spesso inferiori a quelli che fa una farmacia ben gestita dal suo farmacista titolare e non è infrequente constatare che tra i risultati a consuntivo e gli obiettivi prefigurati nei Progetti originariamente presentati agli investitori c’è un consistente gap (che non può essere spiegato soltanto con la congiuntura dell’ultimo anno).
Ciò nonostante, continuano a essere tanti i fondi di private equity che guardano con interesse al canale farmacia (avrò fatto da advisor a una dozzina di loro e condividono quasi tutti le stesse valutazioni) e lo stesso vale per i grandi gruppi europei: Lafayette, giusto per citarne uno, è tornato di recente in Italia a sondare umori e disponibilità. L’opinione prevalente è quella che ancora ho toccato con mano in due recenti tavole rotonde, a Stresa organizzata da Retail Hub e a Cernobbio da Retail Institute; c’è preoccupazione per quello che sta accadendo nel food, nel fashion, nel libro, nelle profumerie, nel grocery, mentre della farmacia si continua a dire che «è l’unico retail resiliente, sicuro e protetto sul quale sviluppare progetti Buy & Build, cioè grandi catene di pharmacy retail».
E invece la verità è che il modello della grande catena di farmacia, schiacciato dall’e-commerce, dalle parafarmacie, dai drugstore, dalle profumerie e dai supermercati, ormai vacilla. Inutile lavorare per avere una bella insegna, una bella vetrina (magari digitale), un category raffinatissimo o volantini con importanti promozioni se poi il cliente-paziente trova oggi gli stessi prodotti, a molto meno, da Acqua e Sapone o Tigotà oppure su Amazon. Diventa legittimo chiedersi se il consumer health venduto in farmacia abbia ancora un futuro e quale, e con lui tutto un modello che ha tentato di replicare il mass-market (non a caso il grosso dei consulenti che lo hanno implementato nelle catene di farmacia arriva da quel canale).
E’ vero che in alcuni casi le catene sono entrate in crisi a causa delle richieste, eccessive, degli investitori. Ma chi viene da esperienze diversificate nel mondo dell’healthcare comincia a intravedere modelli diversi da perseguire: non è un caso che il nuovo ceo di Walgreens venga non dal mondo del retail ma da quello dei servizi sanitari. Forse, anche da noi più che pensare a una catena, con il suo format e il suo category uniforme e standardizzato, bisogna cominciare a ragionare su network più snelli e aggregati attorno a progetti di integrazione olistica nel sistema sanitario.
Il futuro, allora, sarà da costruire su rapporti di collaborazione e partnership con case di cura, Rsa, smart clinic, Case di comunità. Imperniati sull’offerta di servizi che favoriscano l’aderenza terapeutica (cronicità, deblistering), sull’integrazione con altri professionisti della salute (dentisti, ottici, infermieri, biologi), sull’adesione a progetti regionali o nazionali di prevenzione, sullo sviluppo di servizi di telemedicina sempre più evoluti.
In conclusione, è arrivato senz’altro il momento di chiedersi se non stia diventando perdente pensare a una catena nazionale di farmacie orientata al consumer health e modellata sui canoni del consumo di massa. Una catena assemblata comprando e ribrandizzando, con grandi investimenti, farmacie da Trieste a Catania come se l’insegna fosse veramente motivo di scelta tra una farmacia e l’altra (nonostante dicano il contrario tutte le survey fatte sul consumatore finora, l’ultima di Doxa Pharma). Oppure, se non sia meglio ragionare su gruppi locali meno grandi ma integrati nel sistema regionale con l’obiettivo di diventare farmacie di comunità che lavorano sulla presa in carico del paziente, sull’aderenza alla terapia, sul supporto al paziente cronico e in definitiva sulla fiducia con il cliente-paziente, che non viene gestito solo da sofisticati meccanismi di Crm ma anche da farmacisti che lo conoscono personalmente. Intanto, aspettiamo con curiosità i bilanci 2023 di catene e network.